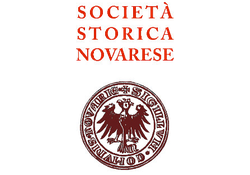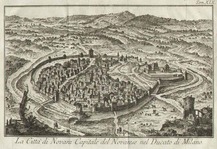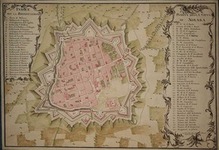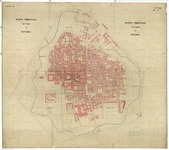La Società Storica Novarese
La prima idea di costituire in Novara una Società che si proponesse l'incremento degli studi storici riguardanti la provincia di Novara sorse nel 1918 in un gruppo di studiosi, che in gran parte facevan capo al Bollettino creato dieci anni prima dal compianto Giovan Battista Morandi. In realtà essa aveva avuto un precedente nella Società archeologica, costituitasi il 21 novembre del 1874 per concorde volere di alcuni generosi cittadini, e che, pur nel breve periodo della propria esistenza - si sciolse il 20 luglio del 1890 - raccolse quel piccolo nucleo di materiali archeologici e artistici i quali formarono il germe del Museo-Archivio lasciato in dono al Comune con l'annesso archivio storico e posto sotto la direzione di Giovanni Battista Morandi.
Merito della Società fu poi il suo arricchirsi di preziose suppellettili provenienti dallo scoprimento della vasta necropoli preromana di San Bernardino, illustrata dal Barocelli.
Nè va dimenticato che contemporaneamente, può dirsi, alla nascita del Bollettino Storico, ancora per iniziativa del Morandi, si formò un gruppo di studiosi i quali si proposero l'esplorazione degli Archivi novaresi e la conseguente pubblicazione dei documenti di cui essi sono ricchissimi; documenti la cui conoscenza è indispensabile a chi voglia conoscere la storia di Novara nel medio evo.
Il gruppo, capitanato da quel formidabile ricercatore di documenti che fu Ferdinando Gabotto, ebbe qui il suo più valido ausilio nel Morandi, a cui si unirono Pietro Fedele, professore nell'Università di Torino e poi Ministro della Pubblica Istruzione, mons. Lino Cassani, Augusto Lizier, Andrea Leone, Guido Audisio, Carlo Salsotto.
Opera loro fu la pubblicazione di una serie di volumi, stampati qui in Novara, e che fanno parte della poderosa raccolta di volumi della Biblioteca della Società Storica Subalpina.
Ma l'idea di fondare la Società Storica Novarese fu ispirata dal desiderio di onorare la memoria del compianto Giovan Battista Morandi. E fu come il ridestarsi del ricordo di ciò che nei primi anni del secolo aveva fatto un minuscolo gruppo di giovani studiosi capitanati dal Morandi: vi appartenevano mons. Cassani, i professori Viglio e Massara e lo scultore Pirotta.
Ecco ciò che ne scrisse, dopo molti anni, mons. Cassani, ormai l'unico superstite: Si vagabondava ogni giovedì nei paesi del Novarese cercando arte nelle chiese, memorie negli archivi, storia nei castelli; si scriveva pro e contro dei nostri ritrovamenti nei giornali di Novara.
L'idea maturò nel 1918 con la formazione di un Comitato promotore di una vera società. Il Comitato si riunì la prima volta il 18 gennaio del 1919: fra le altre proposte per onorare la memoria del Morandi si stabilì di fondare una Società col proposito di continuare l'opera, da lui iniziata con la creazione del Bollettino, incoraggiando e favorendo coi mezzi più opportuni la tutela e il culto delle memorie storiche locali. E nella successiva adunanza del 26 aprile dello stesso anno fu dichiarata costituita la Società Storica Novarese e furono discusse le linee fondamentali dello statuto.
La prima assemblea generale degli aderenti alla Società si tenne il 20 maggio 1920, sotto la presidenza di Alessandro Viglio, già Segretario del Comitato provvisorio. Il Consiglio direttivo risultà composto dai signori Tadini avv. Antonio, presidente, Silva avv. Ettore, vice presidente, Cassani mons. Lino, cassiere, Scarzello prof. Oreste, segretario, Viglio prof. Alessandro, direttore del Bollettino, e dei consiglieri Bronzini ing. Giuseppe, Bustico prof. Guido, Caccia di Romentino avv. Marco, Costa avv. Arturo, Ferrara prof. Stefano, Lampugnani prof. Giuseppe, Lampugnani prof. Rinaldo, Massara prof. Antonio.
Primo atto della Società fu un omaggio alla memoria del proprio ispiratore, assumendo l'amministrazione e l'assegnazione del triennale Premio Morandi creato con il concorso di Enti e di privati, estimatori del dotto scomparso.
A regolare i rapporti tra la Società Storica Novarese e il Bollettino Storico per la Provincia di Novara fu stabilito che questo ne divenisse l'organo, pubblicandone di volta in volta gli atti e inoltre che i Soci fossero di diritto abbonati al Bollettino. Successivamente fu sancito che i precedenti abbonati al Bollettino divenissero soci della Società. Per conseguenza cessò di esistere l'abbonamento al Bollettino, e questo divenne un dono a cui il Socio ha diritto, mentre la quota sociale annua è il mezzo con cui il Socio contribuisce all'esistenza della Società.
È noto che in Italia ben pochi periodici scientifici hanno ripreso, dopo la guerra, la regolarità delle proprie pubblicazioni: per ben ovvie ragioni: tuttavia lo nostra Società nel 1949 e nel 1950 ha donato ai Soci, tra l'altro, due voluminosi fascicoli speciali del Bollettino, entrambi di tale costo tipografico da superare di gran lunga l'importo annuo della quota sociale. E la diffusione del Bollettino si va, di anno in anno, sempre più estendendo fuori della Provincia — anche in centri lontani — col mezzo degli scambi, che recano alla Società periodicamente un notevole numero di riviste e di altre pubblicazioni che la Società affida alla pubblica Biblioteca a vantaggio degli studiosi.
Si aggiunga che la pubblicazione del Bollettino non è l'unica attività di questa associazione. Nel febbraio del 1921 il Consiglio direttivo aveva preso l'iniziativa della commemorazione centenaria degli avvenimenti del 1821, che qui in Novara ebbero il loro epilogo. La celebrazione doveva culminare con la pubblica commemorazione da tenersi dal presidente avv. Tadini nel teatro Coccia; ma le turbolente agitazioni di quel periodo della vita nazionale consigliarono, all'ultimo momento la sospensione della cerimonia.
Frattanto la Società si andava affermando, conquistandosi l'attenzione della cittadinanza, che si manifestava con l'incremento del numero dei soci. E da allora non vi fu iniziativa d'indole culturale che non partisse da essa, od a cui essa non desse l'apporto di fattiva collaborazione. Emerse sempre in questo campo l'appassionata attività del compianto prof. Alessandro Viglio.
E fu la Società a lanciare il grido d'allarme perché la competente Autorità comunale non lasciasse più a lungo deperire, nell'abbandono, insigni monumenti cittadini, testimoni dei tempi più gloriosi della storia di Novara. Di qui l'origine dei lavori per la conservazione delle iscrizioni del Museo lapidario che furono oggetto di studio anche da parte di illustri personalità italiane e straniere; e l'origine delle opere di restauro del Palazzo Pretorio, già sede dell'antico Comune.
I primi assaggi per lo studio di un piano di questo restauro furono compiuti dall'ing. Giuseppe Bronzini, membro del Consiglio direttivo, per incarico affidatogli dal Consiglio stesso.
Diretta emanazione della Società storica novarese fu il Comitato per i restauri della chiesetta della Madonna del Latte di Gionzana, restauri che produssero il recupero d'interessanti affreschi del sec. XV, insigni documenti dell'arte pregaudenziana; e ad altri interessanti studi ricostruttivi di monumenti architettonici diedero opera vari nostri Soci: vanno ricordati in modo particolare l'ing. Bronzini e l'architetto Lazanio, ai quali è dovuta la ricostruzione in disegno, accompagnata da ricerche sui particolari costruttivi e decorativi, della Casa della Ministreria dei Poveri. Ai due soci nominati si unì poi il prof. Rinaldo Lampugnani nei lavori di scoprimento degli affreschi di Santa Maria delle Grazie.
Parimenti il restauro di varie altre antiche chiese fu dovuto alla sagace iniziativa della Società: notevolissimo, a questo proposito, il richiamo alla vita della suggestiva chiesa di San Nazzaro della Costa e dell'annesso Convento.
Degnissima poi di ricordo è la felice opera da essa data per ottenere che il materiale archeologico del Comune di Suno fosse ceduto al nostro Museo lapidario della Canonica, e che nell'atrio del Broletto fossero raccolti gli stemmi marmorei delle illustri Case novaresi, provenienti quasi tutti dagli avanzi dell'antica Cattedrale.
Un'altra attività consistette in una serie di onoranze alla memoria di cittadini novaresi degni di non essere lasciati nell'oblio: il Ravizza, il Morandi, i generali Cavalli e Perrone, l'esploratore Ferrandi. Questo nobile intento è stato rianimato proprio in questi giorni per iniziativa del Sindaco della Città, che ha personalmente inaugurato la nuova serie di rievocazioni di concittadini degni di ricordo.
Ma le vicende della Società non furono sempre liete.
Nel 1935, mentre ne era presidente E. M. Gray, succeduto al defunto avv. Tadini, essa fu sciolta in forza del Decreto del ministro De Vecchi, che soppresse tutte le associazioni del genere, accentrandone l'ufficio nelle Deputazioni regionali: e il Bollettino dovette mutare il proprio titolo in quello di R. Deputazione subalpina di Storia patria, Bollettino della sezione di Novara, iniziando una nuova serie.
Ma nel 1943 esso dovette sospendere la propria pubblicazione, che potà riprendere solamente nel 1947.
Tuttavia, a differenza di ciò che accadde di altre consorelle, la nostra Società non si estinse; e, ritornata in Italia la libertà, potà poi riprendere, sotto la guida di mons. Cassani, nominato Commissario, la propria esistenza, resistendo, come primo atto, al tentativo di annessione ufficiale alla Deputazione supalpina, e riprendendo cosi la propria autonomia, di cui aveva ben ragione di essere gelosa. E per conseguenza il Bollettino riprese il proprio titolo primitivo.
Un segno evidente della non interrotta attività neppure nel periodo sopra indicato è la piena riuscita del XXX Congresso della Deputazione subalpina, qui tenutosi nei giorni 16, 17 e 18 settembre 1937: solenne raduno di studiosi, inauguratosi alla presenza di S.A.R. il Principe di Piemonte. In quell'occasione vennero alla luce, oltre ad altri notevoli studi, i due poderosi volumi delle Consignationes, dovuti all'instancabile attività di mons. Cassani, validamente coadiuvato dal prof. M. Tosi e dal compianto prof. G. Mellerio: l'opera, di capitale importanza per la storia economica delle Parrocchie della Diocesi, fu pubblicata a spese del Comune.
Neppure lo sdoppiamento della Provincia, che distaccò da Novara il Vercellese, il Biellese e parte della Valsesia, non nocque alla Società in quanto non ne diminuì il numero dei soci.
Ripresa nel 1947 la propria esistenza indipendente, la Società elesse a proprio presidente S. E. l'Ambasciatore Vittorio Cerruti, sotto la cui guida si riprese una fervente attività, culminata nelle tre memorabili commemorazioni dei 1° centenario della battaglia della Bicocca, del concittadino esploratore Ugo Ferrandi e del grande vescovo e storico novarese Venerabile Carlo Bascapè. Esse sono così recenti ed hanno destato, specialmente la prima e la terza, così larga adesione di studiosi e così spontanea partecipazione di cittadini di ogni ordine, da non richiedere quasi che ne sia rievocato il ricordo: basti accennare ai due singoli poderosi fascicoli speciali del Bollettino, già ricordati, pubblicati nell'una e nell'altra occasione, e contenenti numerosi scritti che riscossero vivi consensi ( «Studi di storia novarese nel 1° centenario della battaglia del la Bicocca», e «In memoria ed onore del Venerabile Carlo Bascapè vescovo e storico di Novara, nel IV centenario della Sua nascita» ); anzi può ben dirsi, riguardo alla commemorazione del Bascapè, che, come le manifestazioni commemorative novaresi riuscirono una vera apoteosi del grande Vescovo già Segretario di S. Carlo, così gli scritti di quel volume ebbero il merito di contribuire alla ripresa del processo canonico per la sua beatificazione. Nell'una e nell'altra occasione fu allestita e aperta al pubblico una mostra di cimelii entrambe così interessanti da attirare un numero incredibile di visitatori non solamente novaresi ma anche da provincie limitrofe.
È augurabile che l'attività della Società Storica Novarese sia sempre più largamente riconosciuta, e che l'appoggio che la cittadinanza può darle le renda possibile il pieno raggiungimento dei fini propostisi dai suoi fondatori: «illustrare le memorie storiche e artistiche della Provincia... e contribuire alla conoscenza sorveglianza e conservazione delle memorie e delle cose di arte locali».
[Carlo Salsotto, «La Società Storica Novarese» in Novaria - Rassegna di attività municipale, n. 5, marzo 1952]