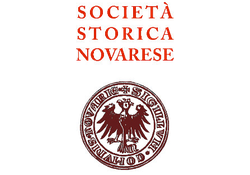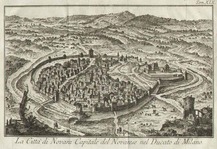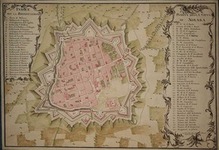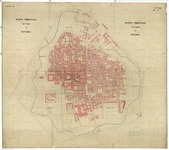Le trascrizioni anagrafiche - Il metodo Ferro
di Luigi Simonetta
[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ]
Località delle Province di Novara e del Verbano Cusio Ossola
fra I Luoghi del Metodo Ferro.
Alcune testimonianze dirette
A titolo di esempio si forniscono qui di seguito alcune testimonianze dirette (cognome e nome del trascrittore, banca dati utilizzata), precisando che vi sono molte altre realtà che collaborano a vario titolo, alle quali per motivi di spazio non stato possibile dare specifica evidenza in questo breve articolo.
Quanto qui esposto non ha quindi il carattere di completezza.
Nella quasi totalità dei luoghi si sono osservati, particolarmente con riferimento ai registri parrocchiali: elevato numero di figli per famiglia; alta mortalit infantile; prevalenza delle professioni legate all’attivit agricola; si giungeva al matrimonio in et molto giovane (specie le donne); la causa di morte per parto non era isolata; i cognomi e nomi di persone sovente variavano in tutto o in parte dal momento della nascita a quella del matrimonio e della morte; registrazioni talvolta poco comprensibili; largo utilizzo di nomi usuali o di soprannomi al posto del nome completo attribuito alla nascita; nelle famiglie si rinnovavano sovente i nomi dai nonni ai nipoti; il cognome delle donne in passato era mancante e nei tempiù più recenti sovente era espresso al femminile; al momento del decesso talvolta la donna veniva registrata erroneamente con il cognome del marito.
Fatta questa piccola premessa si forniscono alcune testimonianze dirette a cominciare dalla prima banca dati avanzata creata con il Metodo Ferro.
Silvano Ferro - (Marcorengo - TO).
Il Metodo Ferro nato dall’unione casuale della passione per le ricerche storiche con l’informatica.
Durante la preparazione del mio libro di storia su Marcorengo ho iniziato infatti a imputare su Excel nascite, matrimoni e decessi dai registri parrocchiali.
Il seguito stato un lavoro di rielaborazione e ricomposizione, per tentativi e senza uno schema preciso, dei dati che avevo caricato.
Alla fine, quasi senza accorgermi, era nata la prima banca dati avanzata (la BDM).
Mancava per ancora una metodologia scritta.
Per scrivere il manuale ho dovuto ripercorrere a ritroso i passi che avevo effettuato, come rivedere un’azione calcistica alla moviola.
L’Incontro dei Marcorenghesi nel mondo nel 2006 stata la pedana di lancio per la pubblicazione della metodologia.
Sono molto contento che altre persone proseguano su questa strada e spero di poter trasmettere la mia esperienza a un numero sempre crescente di trascrittori.
Mario Martinelli e Mauro Lavaselli - (Momperone - Comunità Montana Curone Grue e Ossona in Provincia di Alessandria).
Impressioni e consigli riguardo la creazione della banca dati avanzata di Momperone.
Oltre i passi obbligatori (standardizzazione dei cognomi, ricostruzione famiglie con lo stato delle anime, evidenziazione in grassetto per le registrazioni controllate, scrittura percorsi) un intervento utile da fare potrebbe essere il seguente: inizialmente occorre partire dal file avanzato iniziale (ordinamento standard per anno, mese, giorno, evento e poi per cognomepadresoggetto, nomepadresoggetto, madresoggetto, soggetto) con l’incrocio con lo stato delle anime per cercare di formare le famiglie; successivamente consigliabile ordinare tutto il file per madresoggetto.
L’abbiamo fatto e ci siamo trovati bene, in quanto spesso i padresoggetto si trovano poi quasi tutti vicini e quindi più facile formare le famiglie.
Inoltre il lavoro fatto da due persone senza dubbio più preciso in quanto quattro occhi vedono più di due … e inoltre una persona tira l’altra nei momenti di stanca!
Antonietta Berruti - (Castelnuovo Don Bosco - AT).
Per il comune di Castelnuovo Don Bosco il lavoro di registrazione dei dati stato particolarmente interessante, reso possibile da libri parrocchiali (e comunali) ben conservati che hanno permesso di risalire a nascite, matrimoni e decessi a partire dal 1625.
Inizialmente i registri erano scritti in italiano poi dal 1642 in latino.
Un esempio di cambiamenti con la grafia latina dato dai cognomi Genevro e Genevrero (inizialmente in latino come Juniperus); Giunipero ancora esistente a Berzano di San Pietro.
>Anche il dialetto e i soprannomi hanno influenzato l’origine dei cognomi; a Castelnuovo Don Bosco per esempio sono registrati Berlaita (da siero del latte) e Agagliate (da gai o ghiandaia).
Per quanto riguarda i nomi di battesimo, il nome Luigia molto recente (1800) mentre anticamente i più comuni erano Caterina e Margherita.
Un caratteristico antico nome femminile (1600) Allasina o Alasina.
Anticamente i più comuni nomi maschili erano Bartolomeo, Uberto, Oddone (o Audone) e Guglielmo; il nome più comune Giovanni mentre Giuseppe compare in epoca recente e Mario praticamente inesistente fino alla fine dell’800.
Con la digitazione dei dati si possono seguire avvenimenti come le epidemie o le emigrazioni.
Nel 1630, a causa della peste citata anche dal Manzoni, le annotazioni si interrompono bruscamente ad agosto mentre nel 1632 ci sono nascite registrate con molti mesi di ritardo per rispetto e impedimento della contagione.
A metà del ’600 è frequente trovare famiglie originarie di Cinzano, Berzano di San Pietro e Albugnano, forse da interpretarsi come ripopolamento post epidemia.
Nel 1705 si accentuano le nascite da genitori provenienti da altri paesi (legate forse allo spopolamento dovuto alla guerra che insanguinava Torino, culminata poi con l’assedio del 1706).
Una particolarità il 17 dicembre 1798 la pagina inizia con le parole Libertas-Virtus-Aequalitas (ossia Libertà, Fraternità, Egalità) Republica Gallicana anno septimo et libertatis pedemontanae anno primo .
Il mese quello rivoluzionario, Nevoso, e anche i nomi dei giorni sono cambiati; l’occupazione napoleonica.
Dal 1842 nelle nascite compare anche l’indicazione del mestiere del padre: molti sono tessitori e mantilai, chiaro segno dell’avvento dei telai meccanici e dell’incremento dell’industria tessile nel chierese.
Dallo stesso periodo in poi si pu osservare, con la firma richiesta sugli atti, che la percentuale di coloro che sapevano leggere e scrivere era assai elevata in rapporto ad altre regioni italiane, anche tra persone che esercitavano mestieri quali contadino, tessitore, conducente o falegname.
La prima nascita all’estero quella di un Gilardi, ad Algeri nel 1838.
Nel corso del secolo aumentano le nascite nelle zona di Marsiglia e Nizza, in Provenza e nel Delfinato dove i contadini emigrano in inverno per lavorare nelle fabbriche di zucchero, sapone, salnitro, zolfo.
La crisi agraria del 1880 spinge all’emigrazione anche verso Argentina e Brasile.
Esistono anche fenomeni inversi, cio casi di immigrazione dalla Provenza e dal Delfinato, con famiglie di cognome Chiais e Arnaud.
Con il caricamento dei dati, se fatto con cura e interesse storico, possibile scrivere la storia di 3 secoli della popolazione del territorio.
Guido Corino - (Rivoli - TO).
La mia recente esperienza di trascrittore, attivit del tutto nuova di cui non supponevo minimamente l'esistenza, mi ha portato ad approfondire conoscenze e curiosit del territorio in cui vivo.
Porto due esempi.
Tra le professioni trovavo frequentemente descrizioni tipo: mugnaio ai molini angloamericani oppure tagliatore in lime.
Ho fatto delle ricerche, molto superficiali, e ho appreso che, per il mugnaio, in località Bruere di Rivoli e Collegno, erano attivi numerosi mulini che utilizzavano una tecnologia di macinazione detta angloamericana e che il principale azionista della societ che gestiva tale attivit era la famiglia Cavour.
Per il tagliatore si trattava di operai della fabbrica FILP (Fabbrica Italiana Lime di Precisione) di Cascine Vica.
Era come dire oggi operaio in Fiat.
La considerazione che mi viene di fare che questa attivit di trascrittore, fatta principalmente da pensionati che vogliono occupare parte del loro tempo e che hanno ancora delle curiosit, potrebbe anche essere proposta a studenti, sottoforma di stages o simili, per interessarli al passato del territorio su cui vivono e recepire le modificazioni che questo ha avuto nel tempo.
Roberto Elia - (Lauriano - TO).
L’attività svolta durante l’imputazione dei dati mi ha permesso di toccare con mano ( proprio il caso di dirlo!) le modalit con le quali la registrazione degli atti anagrafici si venuta a evolvere nel corso dei secoli.
Al di là delle svariate difficoltàincontrate, ho avuto modo di ravvisare la comodità di effettuare la copia fotografica dei manoscritti proprio ai fini del caricamento su supporto informatico.
Infatti la generica scarsa disponibilit di accesso agli archivi comporterebbe limitate opportunit di operare, oltre all’assoluta necessit di disporre di un pc portatile.
La fotografia digitale invece, pur dovendo disporre di un tempo aggiuntivo per fotografare e organizzare in cartelle i vari documenti, mi rende possibile procedere nell’attivit di caricamento dei dati direttamente da casa nei ritagli di tempo che mi sono più confacenti.
La digitalizzazione dei documenti originali, inoltre, consente di operare elaborazioni grafiche (ingrandimenti, variazioni del contrasto) che possono risultare utili a una miglior lettura del manoscritto senza dover sottoporre l’originale a continue manipolazioni che, accrescendo l’usura della carta, potrebbero nuocere alla corretta conservazione di documenti il più delle volte unici.
Ettore Molinaro - Sacerdote Cappuccino e Direttore del Museo Civico Craveri di Storia Naturale (per il Gruppo di lavoro di Bra - CN).
Il volto anagrafico agli Antenati.
Quanto resta di loro stato prevalentemente affidato agli Archivi parrocchiali degli ultimi 500 anni, che dopo il Concilio di Trento ha richiesto ai parroci di registrare Cognome e nome/i, Date di Nascita, Morte, Battesimo, Paternit e Maternit, Padrino e Madrina, con le eventuali attivit, Battezzante.
Successivamente venne richiesto di registrare anche i Matrimoni e le date della Prima Comunione e della Cresima e di redigere lo Stato delle anime.
Nel Comune di Bra esistono tre Parrocchie cittadine: S. Giovanni, S. Andrea, S. Antonino, oltre a quelle delle frazioni di Pollenzo, e Bandito; per qualche tempo nella prima met del ’900 vi fu anche Pocapaglia.
Negli archivi Comunali copia dei dati sopraddetti risalgono al 1838, mentre a S. Giovanni gli originali risalgono al 1575 e a S. Andrea al 1583.
Collateralmente all’Anagrafe italiana (1866) vi sono le compilazioni a ritmo decennale, i Censimenti dell’individuo e delle famiglie.
A S. Giovanni nel 1995 si proceduto, previa fotocopia e poi scansione e stampa, a trascrivere su carta a opera della maestra in pensione Elena Botta; il caricamento su computer inizialmente stato affidato a stagisti.
Si aggiunta in seguito la rag. Enrica Borello che ha corretto informaticamente i dati fino al 1941.
Si stima di avere raccolto dati di oltre 23.000 persone.
Sin dagli inizi hanno coordinato questo lavoro di volontariato sia lo scrivente sia il suo braccio destro Claudio Ruzzettu.
Recentemente si sono aggiunti il prof. Silvio Gianti, la maestra Beatrice Panetto, Mariangela Milanini gi dirigente dell’Anagrafe comunale, e alcuni giovani collaboratori dell’Associazione Amici dei Musei di Bra (Alessio Garrone, Francesca Pitzanti, Elisabetta Rinaudi).
Ora il lavoro sta proseguendo con il caricamento dei dati di Nascita-Battesimo di S. Andrea (che conta circa il doppio se non il triplo di quelli di S.
Giovanni) che si sta aggiornando a tutto il XVIII secolo.
Con il metodo di Silvano Ferro, che collabora da circa otto anni, i dati sono confluiti in un archivio delle popolazioni che potr essere fruibile in un prossimo futuro.
Si fa presente che a Bra sino al 1967 esistevano Parrocchie familiari, cio non suddivise per circondari.
I cognomi generalmente indicano quindi appartenenze parentali della stessa citt; questo vale anche per i nuovi arrivati che potevano scegliere il proprio punto di residenza religiosa.
I registri degli Emigranti possono fornire altri preziosi dati.
Nonostante l’enormit del lavoro, ci sembrano indispensabili queste trascrizioni per ridare un volto anagrafico e storico alla popolazione braidese di un tempo.
Gli archivi pubblici privati (ad es. Confraternite e privati) ci daranno le possibilit di indagini e di contributi? Quanti disoccupati nel campo della cultura troverebbero un utilissimo impiego, con la promozione di ricerche e di interessi culturali le quali non escludono anche risvolti economici!
Rolando Balestroni - (Campello Monti - VB, località di antico insediamento walser).
Dai registri delle nascite tra il 1580 e il 1600 un chiaro esempio di cognome che tradisce le origini del Vallese (Svizzera), da cui il nome walser, Todesco e Todesca (ora estinto), dall’aggettivo tedesco, che veniva attribuito a persone di sicura origine germanica.
Gli altri cognomi di famiglie walser (Tensi, Janetti, Guglianetti e Gulienetti) negli antichi registri erano gi scritti in italiano o in latino.
Adriano Negro - (Valsesia - VC: comuni di Alagna Valsesia, Riva Valdobbia, Mollia, Campertogno).
Le ricerche sui registri parrocchiali sono iniziate per il desiderio di risalire ai propri antenati.
Poi prevalsa la decisione di estendere l’imputazione dei dati su una tabella Excel della totalit degli atti presenti sui registri allo scopo di fornire alle parrocchie una base (su supporto cartaceo e CD), per facilitare il compito dei parroci nel rispondere alle numerose richieste, provenienti specialmente da parte dei discendenti degli emigrati.
La base dati, oltre a facilitare la creazione degli alberi genealogici, consente anche varie analisi di tipo demografico, gi prese in considerazione da vari autori (es. stagionalit delle nascite, vita media, emigrazione, ecc.).
In particolare anche interessante studiare l’evoluzione dei patronimici: per esempio in Alagna si osserva che due fratelli De La Pierre, provenienti da Gressoney, a met del 1700 hanno sposato fanciulle alagnesi e hanno dato origine a delle famiglie il cui cognome col tempo sotto l’influenza della cultura Walser diventato Stainer (in tedesco Stein = pietra ).
Altre evoluzioni si notano in alcune famiglie o rami di esse: Zanolti e Gianolti in Grober, Ferraris in Smitt, Farinetti in Malber, Ferro in Balmer o Isman (in tedesco Eisen = ferro), Ronco in Studer, ecc. difficile individuare il motivo di queste evoluzioni dei cognomi per i quali occorrerebbe uno studio approfondito con l’aiuto di altri documenti, come per esempio gli atti notarili, ecc. Si pu solo supporre che in qualche caso il cognome Walser nato forse come soprannome per distinguere alcuni rami della famiglia date le ricorrenti omonimie e poi diventato di uso normale.
L’evoluzione dei patronimici interessa anche i comuni non influenzati dalla cultura Walser: per esempio a Mollia il cognome Avarizia, poi Varizia diventato Marchino; il cognome Capietto dopo alcuni casi di Capietto … detto Giambello diventato Bello.
Adriana Odisio - (Montalero - AL).
Alcune considerazioni personali in merito alla imputazione dei dati del Registro delle nascite del soppresso comune di Montalero dal 1866 al 1899.
Nell’arco temporale di poco più di trent’anni si nota evoluzione linguistica con abbandono di forme arcaiche/dialettali di nomi propri che hanno assunto la struttura grammaticale attualmente in uso (es. Gioanni in Giovanni, Catterina in Caterina, Margarita in Margherita ...). La ricorrenza degli stessi cognomi paterni rivelatrice di un piccolo insediamento a valenza agricola radicato nel territorio, con scarsi fenomeni immigratori di persone dedite prevalentemente ad attivit artigianali. Maggiore la diversificazione dei cognomi materni con l’inserimento nei nuclei famigliari di alcuni cognomi tipici dei paesi viciniori. Dopo il 1890 vengono inseriti nel Registro delle nascite di Montalero anche i nati all’estero, in Francia e prevalentemente a Marsiglia, dove abitavano al momento della nascita entrambi i genitori che avevano conservato ancora legami con il paese di origine. Ci un dato a mio parere significativo di un fenomeno migratorio stanziale di nuclei familiari che si andava ad associare a fenomeni migratori stagionali di singoli braccianti.
Gruppo di lavoro di Cunico - AT.
Osservazioni desunte dal caricamento dei dati (nascite, matrimoni e morti) effettuato a Cunico relativamente agli anni dal 1617 al 1837 (registri parrocchiali) e agli anni dal 1838 al 1899 (registri comunali).
Durante il lavoro sono emersi in particolare i seguenti fatti.
• Nel periodo agosto 1693 - marzo 1694 (otto mesi) sono registrati 127 decessi contro una media, in quegli anni, di 25-30 morti in 12 mesi: si tratt probabilmente di una epidemia;
• tra la fine del 1600 e l’inizio del 1700 risultano registrati alcuni neonati trovatelli (incerti patri, incerti matri) con le seguenti annotazioni:
10 ago 1999 Reperta fuit prop. Capella S. Maria Gratis;
15 apr 1701 repertus in Ecclesia S. M. de Valle (la tuttora esistente chiesa del cimitero);
6 gen 1709 repertus cappella S. Francisci (della quale oggi rimane un pilone votivo dedicato a San Francesco;
• negli anni a met del 1600 si registrano decessi di persone di chiara origine francese senza indicazione di provenienza o mestiere, per esempio:
2 lug 1645 muore ? Pietro detto formetta, francese (il ? sta al posto del cognome evidentemente non conosciuto)
17 ott 1649 muore Ghili Pietro di ? Margaritta e Ghili Santonge, padre francese
15 nov 1649 muore ? Margaritta, marito Ghili Santonge, francese
• all’inizio del 1700 si registra la presenza di soldati francesi, per esempio:
26 gen 1704 muore ? Petrus miles Gallus Regimenti Monleurier
27 gen 1704 muore Voya Anna padre in Regim.to Bourg Lyrlandia
12 feb 1704 muore Merouille Joes Baptista proveniente da Boots de Rochefort, Capitaneus gallus in Regim.to Bassigni
1 feb 1706 muore Sancto Mario proveniente da Gallia ... Capitaneus in Realis Turmis Gallicis.
Piera Sesia - Moransengo (AT).
La ComunitàCollinare Alto Astigiano, di cui il comune di Moransengo fa parte, ha aderito alcuni anni fa all’iniziativa e anche noi, pur essendo uno dei più piccoli comuni dell’Astigiano, abbiamo deciso di prendervi parte.
L’organizzazione iniziale non stata facile; a quel momento ero il sindaco di Moransengo e ho pensato di dare l’esempio e di iniziare la trascrizione insieme a pochi volontari.
L’inizio stato complesso e scoraggiante, non riuscivamo a capire la scrittura, il tempo passava e non si vedevano progressi poi ... ci venuta l’idea di iniziare a trascrivere i registri più recenti e più comprensibili e questo ci ha aiutato ad abituare la vista, a focalizzare subito lo sguardo sui dati di interesse e i risultati sono stati decisamente migliori! In un secondo tempo, fortunatamente, altri volontari si sono uniti al gruppo iniziale e cos siamo riusciti ad informatizzare nascite, matrimoni e morti degli ultimi 50 anni dell’800.
Personalmente devo dire che registrare eventi che, in specifico, hanno segnato la storia della mia famiglia o di parenti e amici mi ha dato momenti di emozione.
Abbiamo anche noi rilevato alcuni elementi ricorrenti quali: totale assenza delle donne nei rapporti con il Comune, mortalit infantile elevata soprattutto nelle coppie molto giovani e analfabete.
L’analfabetismo era concentrato prevalentemente in alcune località del comune.
Abbiamo inoltre conosciuto luoghi che non esistono pi, storie di famiglie di cui avevamo sentito parlare solo nei racconti dei genitori o dei nonni.
Sono passati poco più di 150 anni ma alcune situazioni sembrano lontanissime ... Cito uno degli episodi curiosi incontrati: marito e moglie si presentano in Comune e dichiarano che, nella loro abitazione, da donna che non vuole essere nominata e da padre ignoto nato un bimbo e ... chiedono al sindaco di poterlo adottare! Stiamo ora iniziando la trascrizione dei periodi precedenti l’anno 1866 consultando i registri parrocchiali e speriamo a breve di poter aggiungere le informazioni che ci consentano di ricostruire le storie delle famiglie del nostro paese e di poter mettere questo importante patrimonio storico a disposizione della popolazione di oggi e ... di domani.
Per il futuro del sito, anche in vista di un ampliamento, sarebbe auspicabile un intervento diretto delle istituzioni.