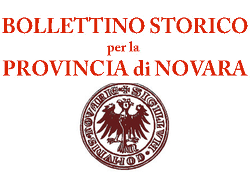Conclusione
La cronologia [4]
Altro elemento di straordinaria importanza per i nostri studi è lo sviluppo dei temi decorativi: e particolarmente del motivo degli archetti pensili.
Fino a qualche anno fa si credeva che questo genere di ornamentazione esterna avesse avuto inizio nel sec.V: la critica più recente, per merito principalmente del compianto A. K. Porter che ha veramente creato i fondamenti dell’archeologia medioevale dell’Italia Settentrionale, ha dimostrato invece che queste architetture hanno avuto origine dalle arcate cieche in uso fin verso il mille e si sono avuti prima archetti a due a due, poi a tre a tre, indi in numero maggiore fino a costituire cornici senza lesene intermedie (21) .
Questa evoluzione è in perfetto accordo con quella dei paramenti: le arcate cieche strette ed alte e gli archetti a coppie dei primi tempi creavano una serie di lesene molto vicine l’una all’altra che animavano la superficie del muro con linee verticali d’ombra cosicché non si poteva seguire l’andamento poco felice dei corsi di materiale minuto formante il paramento: col perfezionamento dell’esecuzione muraria si è preferito, invece, mettere in mostra l’ottimo aspetto delle superfici formate da mattoni o pietrame di buona qualità disposti in corsi orizzontali e quindi si sono diradate ed infine soppresse le lesene.
Si è passati così da un sistema di decorazione di superficie, costituita essenzialmente da riquadri, ad una semplice cornice terminale.
Ritornando ai monumenti novaresi possiamo constatare che i caratteri di maggiore antichità si ritrovano nella cappella del Castello di Caltignaga e nel S.Vittore dell’Isola Superiore. Questo era decorato nell’abside e nei muri da arcate cieche ed aveva finestre abbastanza ampie, elementi che tendono a farlo attribuire a data anteriore al mille. La scarsezza di elementi stilistici ostacola invero una determinazione esatta, tanto più che i monumenti carolingi sono pochi ed incerti: pare tuttavia che il motivo delle arcate cieche esterne, usate specialmente nel V e VI secolo, si sia mantenuto in uso fino alla fine del X secolo: lo troviamo ancora in edifici di età poco lontana dal mille (S.Vincenzo di Galliano, 1008, etc.) (22) ; indicheremo quindi per la nostra cappella l’ultimo quarto del X secolo pur facendo opportune, prudenziali riserve.
Per la chiesetta di Caltignaga nella parte più antica si può supporre una data analoga: gli archetti pensili a coppie con una grossa mensola intermedia (23) le arcate cieche del campanile, la rozza muratura stanno concordi ad attestarne l’antichità: l’epoca proposta è poi in accordo con la storia del castello circostante il quale godette senza dubbio un periodo di floridezza ai tempi di Ildeprando (+ prima del 958) e dei suoi discendenti immediati.
All’ultimo quarto di secolo risale probabilmente S.Nicola “alla Barazzola” presso Borgomanero: il campanile è una semplice canna di muratura come la torre dei monaci presso s.Ambrogio di Milano e la chiesa è decorata da archetti a coppie solo nell’abside. Noi sappiamo inoltre che la corte di Barazzola fu donata al Capitolo dell’Isola S.Giulio nel 962: è naturale congetturare che i canonici abbiano voluto fornire al più presto la loro nuova proprietà di una chiesa onde dare agli abitanti possibilità di assistere con comodità alle funzioni religiose.
Il Capitolo dell’Isola ebbe pure in dono nel 962 la corte di Agrate: possiamo dunque sospettare che anche la parte più antica del battistero di questo paese, di pianta semplicemente circolare e formata di muratura molto rozza, risalga all’ultimo quarto del X secolo.
Questa attribuzione cronologica non può tuttavia essere formulata senza riserve poiché il monumento conserva elementi molto scarsi della costruzione primitiva: non così, invece per le chiese della Barazzola e di Caltignaga.
La data indicata per queste due ultime è infatti in perfetto accordo con quanto si conosce sulle origini dello stile romanico poiché pare che il motivo degli archetti pensili a coppie sia stato usato le prime volte appunto nella seconda metà del sec.X (24) .
Decorazioni di questo genere hanno anche le chiese di s.Genesio di Suno, s.Marcello di Paruzzaro e S.Martino di Pombia che possono riferirsi al primo quarto dell’XI secolo e quelle di s.Martino di Romagnano, s.Tommaso di Briga, s.Pietro di Marzalesco, s.Giulio di Cressa ed i campanili di Braccino, Massino, Villalesa e Villadossola che penso risalgano invece al secondo quarto.
Gli elementi di giudizio che ci offrono s.Genesio di Suno sono la rozza muratura, i grossi archetti a coppie e le finestre a semplice strombatura: s.Marcello di Paruzzaro ci presenta anch’esso rozzi paramenti e decorazioni di archetti a coppie nella sola abside: s.Martino di Pombia presenta archetti a due a due nell’abside e nella facciata e supporti disordinati e strani fra le navate: pilastri ottagonali in muratura, pilastrini e fusti di sezione rettangolare o tonda coronati da pulvini appena sbozzati.
Ora noi troviamo supporti monolitici quasi identici nel s.Vincenzo di Galliano (1008) (25) (pilastrini quadrati o rettangolari con pulvini appena sbozzati) e nel s.Giorgio di Valpolicella che recenti indagini hanno dimostrato omogeneo (26) e di epoca vicina al mille: d’altra parte i pilastri ottagonali sono veramente caratteristici della primitiva arte romanica e se ne conoscono numerosissimi esempi (fra gli altri s.Pietro di Acqui datato 989-1018).
Il gruppo successivo di edifici mostra un notevole miglioramento nella tecnica costruttiva rispetto a quelli testà citati: la muratura è eseguita con maggior cura ed i ciottoli ed i frammenti di cotto che formano i paramenti sono disposti in qualche tratto a spina pesce: gli archetti pensili sono sempre a coppie ma le dimensioni di essi sono minori e la disposizione dei materiali che formano le parti in curva è più curata.
Tenendo presente questa evoluzione si possono assegnare, con un procedimento di interpolazione, i monumenti predetti al secondo quarto del sec.XI. Una conferma delle date riferite sé può ottenere ad ogni modo dal confronto con s.Pietro d’Acqui (989-1018) (27) e s.Giustina di Sezzadio (a. 1030) (28) due monumenti che hanno una sicura fede di nascita.
Allo stesso periodo di tempo vanno riferiti, probabilmente, s.Vincenzo di Pombia e s.Pietro di Carpignano, due monumenti coperti da volte a crociera. Questi edifici hanno sempre murature rozze e molti segni di grande antichità ma hanno archetti aggruppati a tre a tre interpolati ad altri coppie: vanno quindi attribuiti alla fine del periodo citato, cioé verso il 1050: ad ogni modo una data molto più recente di questa per la parrocchiale di Pombia non sembra in accordo con la storia locale, poiché il paese godette un periodo di fortuna sotto i Conti di Pombia fin verso la metà di quel secolo mentre nel periodo susseguente questa nobile famiglia dovette cedere il suo possesso avito ai vescovi novaresi. Questi, a quanto pare, non furono molto teneri con la roccaforte del partito avverso anzi crearono una nuova chiesa in Varallo Pombia e probabilmente trasferirono in essa le funzioni e la dignità plebana di s.Vincenzo.
Al terzo quarto dell’ XI secolo si possono attribuire poi le chiese di Casalvolone (nella prima costruzione a tetto), s.Michele di Oleggio, Candoglia, la parrocchiale di Cureggio, S.Pietro di Ghemme, ed i campanili di S.Giuliano di Gozzano, S.Maria di Suna, Pallanzeno e Paruzzaro.
Tutti questi monumenti presentano un marcato sviluppo nella decorazione di archetti pensili (in gruppi di tre o quattro ed eccezionalmente in numero maggiore) e nelle murature. Queste sono sempre rozze ma i ciottoli ed i frammenti di cotto sono disposti in buona parte a spina pesce e qua e là si trovano anche mattoni nuovi del tempo, (Casalvolone, etc.).
L’uso dello “spina pesce” è proporzionale invece al quantitativo di materiale di seconda mano poiché questa disposizione era adottata per ottenere un buon risultato estetico e costruttivo con materiali minuti ed irregolari: variando l’inclinazione di ogni elemento si riusciva ad ottenere una costante altezza nel corso ed il paramento risultava formato di tante striscie orizzontali di aspetto regolare anche se composto di frammenti.
Evidentemente non era possibile ottenere lo stesso risultato collocando i materiali minuti a mosaico od orizzontalmente e la disposizione a spina pesce va considerata come una raffinatezza costruttiva che ha subito anch’essa una certa evoluzione: negli edifici della prima metà del secolo i frammenti di cotto (generalmente tegole) erano rozzi e di dimensioni varie mentre in quelli della fine del secolo ed ancor più negli altri del sec.XII si osserva forma parallelepipeda regolare e disposizione molto accurata con sottili letti di malta.
Sull’evoluzione della muratura in pietrame, dai frammenti informi del principio del secolo alla pietra concia della fine non mi pare sia il caso di insistere.
Noi abbiamo ad ogni modo un chiaro riferimento per l’architettura del terzo quarto dell’XI secolo; la cattedrale di Acqui che fu consacrata nel 1063 (29) : essa ci presenta uno stile un poco più progredito dei nostri monumenti ma bisogna tener conto dell’arcaismo delle località rurali e della possibilità che la consacrazione acquense sia stata fatta ad edificio incompiuto.
Al periodo 1075-1100 possiamo riferire S.Pietro di Casalino, S.Maria di Garbagna, le chiesette dei cimiteri di Sologno, Sillavengo e Caltignaga ed i campanili di Momo, Pettenasco, S.Filiberto in Prorio presso Alzo, Armeno, Crusinallo, Masera e Gravellona Toce ed infine la cupola con le cornici a nicchiette ed archetti del battistero di Novara e la parte superiore del S.Lupo di Caltignaga.
Tutti questi edifici presentano strutture di mattoni in corsi quasi orizzontali o di ciottoli a spina pesce: non è ancora eliminato pertanto l’uso dei materiali di spoglio che ritroviamo a Casalino, Sologno e Garbagna, né si ottiene ancora una scrupolosa regolarità nella collocazione e nella scelta dei ciottoli e dei frammenti lapidei. La decorazione di archetti pensili si sviluppa poi in cornici senza lesene intermedie (Caltignaga, Casalino etc.).
L’epoca di costruzione può stabilirsi senza difficoltà per interpolazione tenendo presenti i caratteri dei monumenti del primo e secondo quarto del sec.XII.
»»» continua ./.
(21) A. K. PORTER: Lombard Architecture I pag.224 ss.PUIG Y CADAFALCH: La geografia y els origens etc. pass.
(22) A. K. PORTER: ‘Spanish romanesque sculpture, nota (81) pag.91; PUIG Y CADAFALCH: op. cit. pag 95 ss.
(23) Cfr. su questo particolare; PUIG Y CADAFALCH: op. cit. pag.120.
(24) Così le chiese di Amer e Sancta Cecilia in Montserrat nella Catalogna; (PUIG Y CADAFALCH: L’Arquitectura romanica a Catalunya II pag.134-138).
(25) Cfr. PORTER: Lomb. Arch. II pag.439 ss.Per le condizioni originali del monumento cfr. ANNONI; Monumenti del Borgo di Canturio pass.e specialmente tav. VII A e VII B.
(26) DA LISCA: S.Giorgio di Valpolicella (Estr. Miscell. Nozze Brenzoni-Giacometti).
(27) PORTER: Lomb. Arch. II pag.25 ss.e MESTURINO: La Basilica latina di S.Pietro.
(28) GASPAROLO: S.Giustina di Sezz�; PORTER: Lomb. Arch. III pag.567 ss.
(29) PORTER: Lomb. Arch. II pag.14 ss.