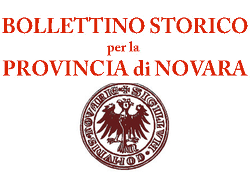Conclusione
La cronologia [5]
Dopo il mille e cento comincia infatti per noi un periodo molto più chiaro dal punto di vista della cronologia: i monumenti ben datati non mancano e quindi noi abbiamo basi sicure di riferimento.
Al primo quarto del secolo si possono riferire le chiese di Ognissanti a Novara, Varallo Pombia, S.Remigio di Pallanza, Gravellona Toce, S.Sebastiano di Lesa, Cavaglietto, S.Giacomo al Basso e Bogogno, nonché il battistero di Cureggio ed i campanili di Arona, Belgirate, Borgoticino e S.Maria Vecchia di Sillavengo.
Tutti questi edifici mostrano ormai lo stile romanico sviluppato, sia pure in modeste e povere forme rurali ed hanno riscontro nei monumenti datati di S.Pietro di Casalvolone (ricostruzione a volta) e del distrutto S.Ambrogio di Novara.
Chiara è l’evoluzione dei paramenti: quelli in cotto sono composti in parte di laterizi nuovi, disposti in corsi orizzontali o quasi, mentre le porzioni eseguite di materiali minuti di ricupero mostrano frammenti tagliati in forma di parallelogramma, esattamente collocati con sottili giunti di malta (Casalvolone, Ognissanti di Novara, campanile di Sillavengo etc.): altri di pietrame hanno negli spigoli e nelle parti di maggiore importanza strutturale od estetica, blocchi squadrati (anche se imperfettamente) frammisti a mattoni e pietrame (Varallo Pombia, Pallanza): altri ancora hanno ciottoli accuratamente disposti nelle specchiature e cortine murarie con linee orizzontali ed oblique tracciate sulla malta fresca per indicare e rendere più regolari alla vista i corsi a spina pesce (Bogogno etc.).
Né mancano gli esempi di ornamenti plastici sia pure in forme sommarie: i capitelli di Pallanza, Novara e Casalvolone e le finestre di Varallo Pombia ci offrono chiare testimonianze di uno stile decorativo semplice ma forte e vivo.
La chiesa di Cavaglietto è priva di decorazioni ma l’epoca di costruzione è indicata dal carattere dei paramenti accurati di ciottoli a spina pesce e segnati da linee incise sulla calce e la data proposta è in pieno accordo con le notizie sulla fondazione del monastero (c. 1100). Siamo ora giunti al secondo quarto del XII secolo, nel quale per nostra buona fortuna non fanno difetto i monumenti autentici.
Il Duomo di Novara, consacrato nel 1132 e tutto il gruppo di chiese consacrate dal vescovo Litifredo (o dal suo predecessore Riccardo): la “Cella” di Proh, S.Martino di Gattico, S.Giulio di Dulzago, S.Ambrogio di Cavaglio, la parrocchiale di Dormelletto, il battistero di Agrate nel rifacimento del sec.XII e probabilmente anche le chiese di Briona e Trobaso, ci danno una chiara idea delle condizioni dell’architettura nel periodo 1118-1144: una ulteriore conferma si ha dalla chiesa di Conturbia e dai resti dell’antica parrocchiale di S.Maria Maggiore consacrate ambedue prima del 1154 e dalla Canonica del Duomo Novarese opera anch’essa dei tempi di Litefredo per quel poco che si può riconoscere nella costruzione del sec.XV.
Possiamo quindi riferire con piena tranquillità allo stesso periodo gli altri monumenti simili e cioé: la bella chiesa di S.Giulio d’Orta, S.Lorenzo di Gozzano, S.Iginio di Gattico, S.Leonardo di Borgomanero ed i campanili di S.Maria di Mergozzo e di Gargallo, probabilmente contemporanei alle chiese attigue, ora distrutte, che sappiamo consacrate da Litefredo.
Non credo vi sia bisogno di insistere sulle ragioni che mi inducono a proporre questa datazione: la somiglianza fra le strutture dell’antico Duomo di Novara e di S.Giulio d’Orta con gallerie sulle navatelle, torri in facciata e cupola sono evidenti: le caratteristiche comuni fra le decorazioni ed i paramenti in blocchi di serizzo di quest’ultima chiesa, della attuale S.Marta in Mergozzo e delle basiliche consacrate da Litefredo (Cavaglio, Gattico, Conturbia etc.) sono troppo evidenti agli occhi del lettore.
È probabile che al secondo quarto del secolo appartenesse pure l’antico S.Giuliano di Gozzano, il quale doveva avere struttura quasi identica a quella del S.Giulio d’Orta e del Duomo di Novara: la scomparsa del monumento ci impone tuttavia una prudente riserva in proposito.
La chiesa del Cimitero di Briona ha strutture ed ornamenti che ricordano quelli del S.Giulio di Dulzago ed ha pure somiglianza col S.Pietro di Casalvolone quantunque appaia più recente di esso: l’identificazione con l’ “ecclesia Petrorii”, consacrata da Litefredo, troverebbe adunque piena conferma nello stile. Infine la cappella di S.Leonardo in Borgomanero e le altre costruzioni simili, a contrafforti esterni alti come il muro di perimetro (S.Iginio di Gattico, S.Lorenzo di Gozzano) possono essere paragonate alla parrocchiale di Dormelletto. Una conferma si ha dai caratteri delle murature: per esempio il paramento dell’abside del S.Lorenzo di Gozzano in ciottoli ben disposti a spina pesce listati da mattoni è simile a quello del S.Giulio di Dulzago.
Al terzo quarto del secolo potremo riferire la parrocchiale ed il battistero di Baveno, le chiese di Armeno e Crusinallo, il S.Giovanni di Montorfano, la cappella di Antoliva e quella del cimitero di Bracchio, S.Bartolomeo di Villadossola e i campanili delle parrocchiali di Paruzzaro, S.Maria Maggiore e Nonio.
È anzitutto evidente che le cornici di archetti intrecciati che si osservano ad Armeno ed a S.Giovanni di Montorfano, le modanature ricorrenti intorno alle porte ed alle finestre di questi due monumenti e del S.Bartolomeo di Villadossola e la finestra a quadrifoglio della parrocchiale di Baveno corrispondono ad una fase avanzata di sviluppo della decorazione romanica che procede in pieno accordo con la perfezione tecnica dei paramenti della cappella di Bracchio e delle chiese di Antoliva ed Armeno.
Nella valutazione cronologica dei caratteri stilistici non dobbiamo tuttavia dimenticare che i nostri monumenti sorgono in paesi rurali, lontani da grandi centri: non potrà quindi stupirci l’arcaismo di certe forme, per esempio la rozzezza delle scolture della chiesa di Armeno: nella vicina basilica di S.Giulio d’Orta coesistono capitelli ben disegnati e scolpiti ed altri rozzissimi. La matura sensibilità degli architetti risalta per altro dallo studio delle proporzioni e dalla cura dei particolari: si può citare l’eleganza e lo slancio del campanile di S.Bartolomeo di Villadossola nel quale si è voluto giustamente vedere una delle più belle torri del genere esistenti nell’Italia Settentrionale.
Resta da studiare solo più l’ultimo quarto di secolo prima del duecento: purtroppo anche in questo periodo non esiste alcun monumento autenticamente datato.
Giudicando dallo stile penso possano attribuirsi al periodo 1175-1200 le chiese di S.Quirico di Domodossola, S.Sebastiano di Suna, S.Maria d’Ingalardo a Novara, S.Maria di Galnago, S.Maria di Caltignaga ed i campanili di Megolo, Seppiana e Crevola d’Ossola.
S.Quirico di Domodossola e S.Maria di Galnago hanno qualche arco che accenna leggermente all’acuto e fa presentire vicino lo stile gotico: nella chiesetta di Galnago si ritrovano cornici composte di quei mattoni stampati a losanghe in rilievo che erano usati fra di noi nella seconda metà del sec.XII e nel XIII.
Il S.Sebastiano di Suna ci presenta paramenti accuratissimi di pietra concia, finestre di proporzioni molto slanciate secondo uno schema che diverrà frequente nel periodo gotico: gli archetti pensili e gli archivolti delle stesse finestre hanno il bordo arrotondato e percorso da una linea incisa.
La cappella di S.Maria di Ingalardo, sebbene ci presenti ormai resti così scarsi dell’antica struttura da non permettere un giudizio sicuro, dimostra la sua età per la finezza della muratura eseguita di mattoni nuovi e l’eccellente apparecchio degli elementi della cornice in ottimi laterizi lisciati: la riproduzione dello schema protoromanico degli archetti a coppie deve essere interpretato come una curiosità decorativa, non infrequente del resto nel sec.XII, specie nell’Emilia.
Chiari esempi di arcaismo nel significato più ampio della parola sono pure i resti della chiesetta di Levo ed i campanili di Megolo, Seppiana e Crevola d’Ossola i quali tradiscono la propria scarsa antichità per la fiacchezza di espressione degli elementi decorativi: essi potrebbero anzi esser stati eretti anche in epoca posteriore al duecento.
Gli elementi dello stile romanico sono durati infatti per lungo tempo nel repertorio dei costruttori rurali riprodotti senza vita per forza di abitudine e spirito di conservazione: un chiaro ed evidente esempio di tardo impiego degli schemi romanici si osserva nel S.Ambrogio di Omegna, costruito di blocchi squadrati di serizzo e fornito di cornici di archetti pensili nel sec.XIII: chi lo osserva all’esterno in modo sommario può credere sia opera del sec.XII, ma penetrando all’interno e studiando meglio i particolari dell’opera sorgono gravi dubbi sulla sua antichità poiché per molti elementi di trascuratezza o di carattere gotico, essa indica il suo arcaismo.