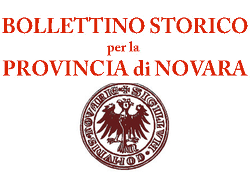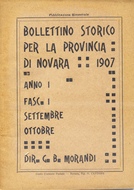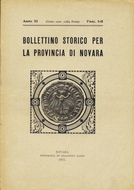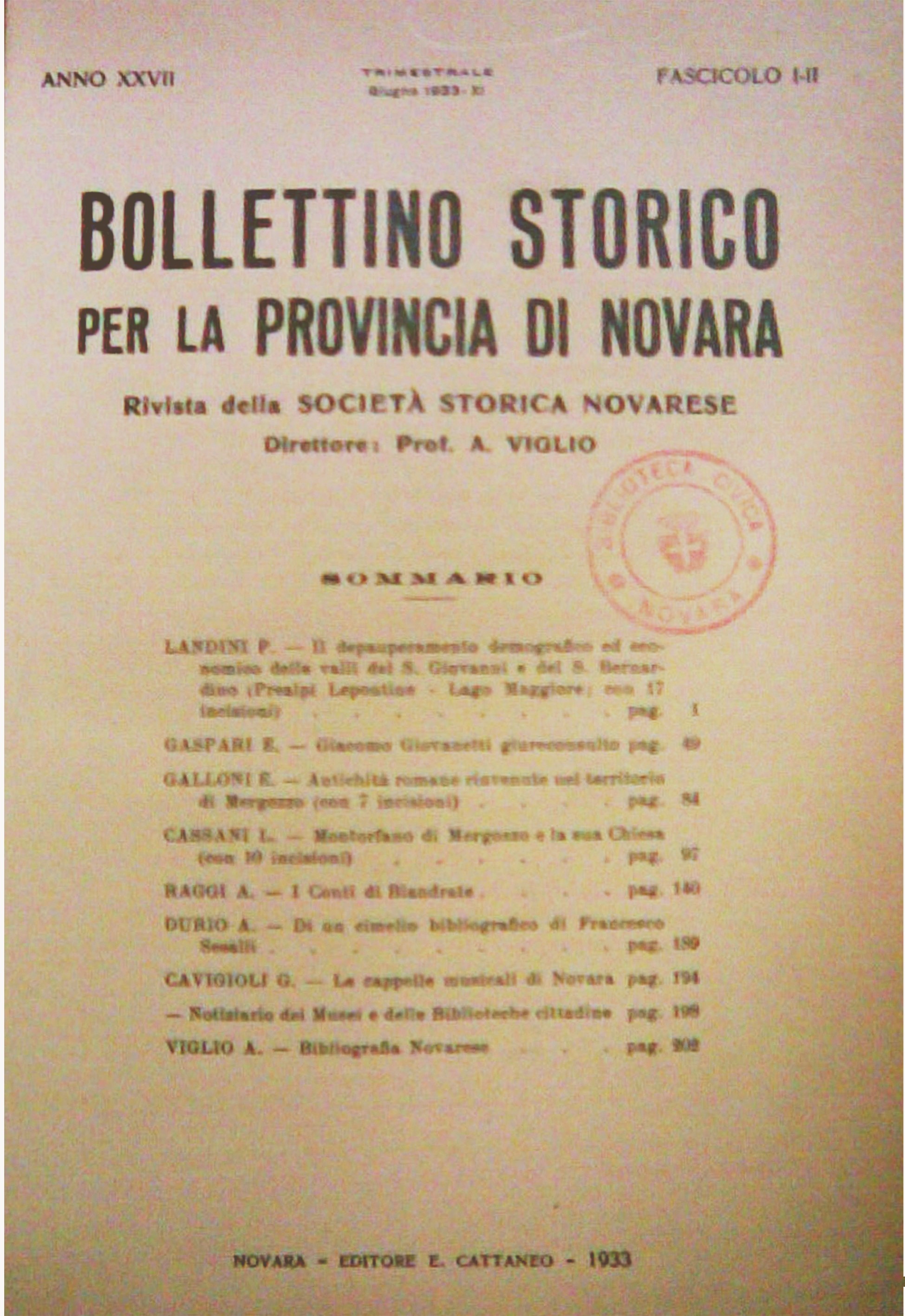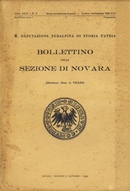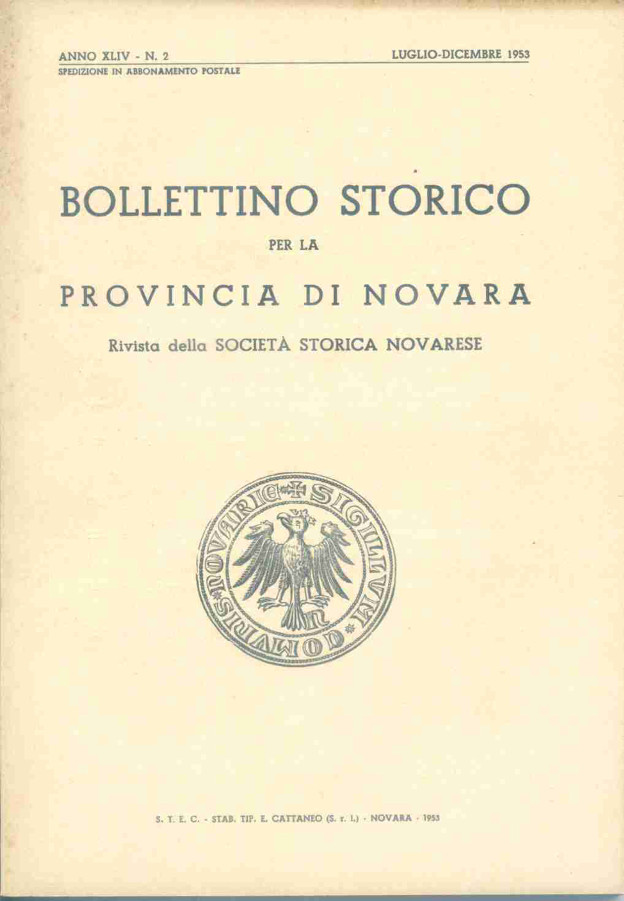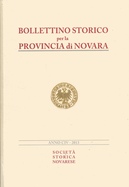Segnalazioni di tesi di laurea
In questo periodo di grande difficoltà per il mondo della ricerca, intendiamo rilanciare l'interesse verso i lavori di ricerca portati a termine dagli studenti universitari che hanno focalizzato la propria attenzione sui temi della storia e della cultura del territorio.
Dopo l'istituzione, nel marzo 1970 e l'apertura al pubblico, due anni dopo, dell'Archivio di Stato di Novara, molte sono state le ricerche condotte presso tale Istituto ai fini di tesi di laurea. Solo una minoranza dei laureati ha però adempiuto all'obbligo, che è in primo luogo morale, di consegnare all'Archivio una copia della tesi.
Di tali contributi storiografici, caratterizzati da serietà e rigore scientifico, riteniamo opportuno dare sintetica indicazione (1).
1969
Elio FRONTINI, Giacomo Giovanetti ed i problemi economici del Piemonte nell'età albertina. Università Cattolica del Sacro Cuore, Facoltà di Economia e Commercio, a.a. 1968-69.
Le carte del Giovanetti, già conservate presso la Biblioteca Civica Negroni e ora depositate all'Archivio di Stato, sono state tra le fonti principali utilizzate dall'Autore per uno studio del pensiero dell'uomo politico novarese, messo in connessione con la situazione dell'agricoltura e dell'industria manifatturiera, nonchè della scuola e dell’istruzione, in Piemonte durante il regno di Carlo Alberto.
1973
Tiziano MARAGNO, L'industria manifatturiera nel Dipartimento del» l'Agogna (1800-1814). Università degli Studi di Torino, Facoltà di Magistero, a.a. 1972-73.
La documentazione esistente nell'archivio della Prefettura del Dipartimento dell’Agogna, di agevolissima consultazione per l'organicità interna che caratterizza soprattutto le categorie riferentisi all'industria manifatturiera, è la miniera di dati che l'Autore sagacemente utilizza per comporre un quadro ricco e articolato dell'attività industriale del periodo, nelle sue varie espressioni: la lavorazione della canapa, del lino, del cotone, della seta, della lana e la concia delle pelli e dei cuoi.
1976
Angela MESITI, Lomellina e Vigevanasco in età "Francese", L'agricoltura. Università degli Studi di Pavia, Facoltà di Lettere e Filosofia, a.a. 1975-76.
Attraverso un esame approfondito delle serie archivistiche appartenenti al fondo della Prefettura Dipartimentale dell’Agogna l'Autrice ha tracciato un quadro denso e completo della situazione dell'agricoltura, dell'allevamento e del commercio dei prodotti agricoli in età napoleonica in quelle province, già sabaude, riunite in un unico distretto all’epoca della Repubblica Italiana e del Regno d’Italia.
1977
Maria PAGNUCCO, Un moderato piemontese del Risorgimento: Giacomo Giovanetti. Università degli Studi di Milano, Facoltà di Lettere e Filosofia, a.a. 1976-77.
L'Autrice ha studiato il pensiero del giurista e uomo - politico novarese, enuncleandone tre aspetti fondamentali; il liberismo in economia e la sua disciplina da parte dello Stato, i fattori del progresso sociale, l'apparato istituzionale.
L'Autrice ha utilizzato, oltre a tutti gli iscritti editi del Giovannetti, di cui offre una completa bibliografia, altresì una serie di carte, appunti, manoscritti e lettere che formano un nucleo dell'archivio privato del giureconsulto novarese e che si trovano presso l'Archivio di Stato, Fondo Museo.
1978
Gaudenzio DE PAOLI, Il Monte di Pietà e il problema dell'assistenza ai poveri a Novara tra ‘700 e '800. Università degli Studi di Milano, Facoltà di Lettere e Filosofia, a.a. 1977-78.
L'organizzazione assistenziale nelle sue varie articolazioni e nelle sue numerose forme di intervento forma l'oggetto di questa ricerca, nella quale l'Autore dimostra il ruolo fondamentale esercitato dal Monte di Pietà « Amico Canobio » nella direzione e nel coordinamento del complesso dell'attività caritativa novarese.
Marina MARINI, Caratteristiche dell'infanzia abbandonata a Novara nella seconda metà dell'800. Università degli Studi di Milano, Facoltà di Lettere e Filosofia, a.a. 1977-78.
L'Autrice mostra come le trasformazioni economiche, sociali e demografiche, verificatesi in provincia di Novara nella seconda metà dell’Ottocento, abbiano avuto ripercussioni sul modo di concepire e di attuare la assistenza all'infanzia abbandonata».
Pia SARUBBI, Una famiglia nobile novarese nel tardo Medioevo: i Cattaneo di Sillavengo. Università degli Studi di Torino, Facoltà di Magistero, a.a. 1977-78.
L'intento dell'’Autrice è stato quello di ricostruire le vicende famigliari, il ruolo sociale e soprattutto la consistenza patrimoniale di un’antica e cospicua famiglia novarese, studiando un centinaio di pergamene, che sono la parte superstiste più antica dell'archivio dei Cattaneo. L'Autrice ha altresì messo a fuoco il problema, per più versi ancora insoluto, della conoscenza dell'istituto del « capitaneato », rilevando in particolare i risultati acquisiti dalla storiografia sui « capitanei » di Novara e di Milano.
1979
Valeria GNEMMI, Ricerche sul «Contado» novarese nel XVII secolo (1645-1675). Università degli Studi di Milano, Facoltà di Lettere e Filosofia, a.a. 1978-79.
Attraverso lo spoglio sistematico del fondo « Contado di Novara », l'Autrice ha messo in luce la struttura, il funzionamento e le vicende trentennali di un organismo amministrativo per sua natura ibrido, nel quale cioè risulta molto spesso arduo separare nettamente gli elementi di autonomia da quelli di dipendenza gerarchica dalle magistrature centrali dello Stato di Milano.
Oltre quaranta sono state in seguito le tesi di laurea segnalate nella sezione Thesis del Bollettino tra la seconda metà degli anno '80 ed i primi anni del nuovo millennio.
Le più interessanti, una decina, hanno poi trovato spazio per una più estesa pubblicazione nel Bollettino stesso.
Talune, a riprova del valore degli studi segnalati, sono sfociate in autonome pubblicazioni.
La brusca interruzione avvenuta dopo il 2002 può essere letta come una, spiacevole, conseguenza della riforma universitaria del 1999, che ha, di fatto, impoverito la qualità dei percorsi formativi "magistrali", come più volte segnalato dai più attenti osservatori del mondo accademico.
La particolare evidenza data a questo spazio vuole quindi essere di stimolo, e di supporto, al mondo della ricerca universitaria, mettendo a disposizione uno spazio qualificato e "garantito" dal Comitato scientifico, nella speranza di poter presto arricchire questa sezione con la segnalazione di nuovo studi.
1984
Filippo Morgantini, Edoardo Arborio Mella restauratore. ![]()
Antonella Guaita, L'assetto urbanistico del centro storico di Novara dal 1552 al 1810. In particolare gli edifici conventuali ed ecclesiastici.
... i gradi di licenza, e Laurea dovranno conferirsi dall'Arcivescovo, o suo Vicario in pien Collegio di quella Facoltà, nella quale vorrà lo Studente essere graduato... Nel giorno prefisso per la collazione del grado di Licenza, Laurea, o Aggregazione, si congregherà il Collegio nella sala dell'Università destinata per le funzioni pubbliche. Accompagnato dal Promotore, e preceduto dal Bidello della Facoltà con mazza, entrerà nella sala il Candidato colle sue divise... Salito quindi sulla Cattedra reciterà una breve prefazione, ed esporrà in succinto le materie, che dee difendere... (2), quattro Dottori del Collegio interrogavano poi il Candidato sulle materie esposte nella tesi, seguiva la votazione, quindi il giuramento alle Regie Costituzioni ed infine venivano conferite le onorevoli insegne di laurea.
Questa era, per l'esame di laurea, la procedura prevista dalle Costituzioni e Regolamenti per l'Università di Torino dell'anno 1772, rituale scenografico che trovava giustificazione nel costume del tempo e nell'intento di solennizzare il giorno conclusivo del corso di studi.
Oggi disusi toga, collare e berretta si può discutere la laurea in maglione e jeans, l'Arcivescovo ed il suo Vicario presiedono a cerimonie diverse, anche il Bidello ha perso la mazza: l'evolversi della società e del gusto hanno cancellato ogni cerimoniale al conferimento della laurea ma non penso possa essere diminuito il significato di questo giorno che, concludendo un periodo della vita, inserisce nel mondo del lavoro, delle responsabilità, anche delle incertezze dell'avvenire.
Il giorno della discussione della tesi è tuttavia spesso ricordato come un giorno che non paga; il rapporto tra i lunghi mesi impegnati nello studio e nella ricerca e la scarsa frazione di ora concessa per esporre e discutere l'argomento ha come risultato quasi costante un senso di delusione.
Il nostro tempo rifiuta le formalità, viviamo un'epoca che vorremmo razionale ma anche un'epoca avara nel concedere soddisfazioni.
La stesura di una tesi, soprattutto di una buona tesi, è un impegno non indifferente: si scava nell'argomento, lo si fa proprio, in un certo senso ci si affeziona, spesso viene raccolto materiale interessante anche per successive ricerche, ma il dattiloscritto è destinato a concludere il suo iter, almeno nella maggior parte dei casi, sconosciuto e dimenticato nei grandi scaffali delle Università.
Lo scopo di questa rubrica è dare un senso di continuità ad almeno alcuni di questi studi (3). In questi anni numerose sono state le tesi che hanno avuto per argomento il nostro territorio con indagini nel campo archeologico, storico, archivistico, con ricerche architettoniche e monumentali, con analisi sociali.
Costituiscono un impegno che ci sembra giusto riconoscere e far conoscere, rappresentano un dato indicativo degli indirizzi che oggi segue la ricerca universitaria, sono fonte di informazione ed incentivo per nuovi studi.
Di ogni tesi verranno precisati i riferimenti essenziali: autore, relatore, Università e Facoltà, anno accademico, luogo ove può essere consultata.
L'argomento verrà esposto, ogni volta che sarà possibile, dallo stesso autore in un breve riassunto che dovrebbe indicare i motivi della scelta del tema, il piano di lavoro, le conclusioni dell'indagine svolta.
Non verrà evidentemente espresso alcun giudizio, in primo luogo perché non di nostra competenza ed inoltre perché esulerebbe dall'intento di questa rubrica che ha per scopo non di recensire ma di segnalare e far conoscere gli studi compiuti dai laureandi delle nostre Università.
Vorremmo concludere ringraziando tutti gli studenti e laureati che hanno scelto per la loro tesi un tema connesso al nostro territorio, con l'invito a segnalarci le loro ricerche, concluse o in corso, per dare continuità a questa nostra iniziativa.
Franca Maulini Colombo [in BSPN LXXVI (1985)]
1985
E. Cavallini, C. Cracchi, W. Fasola, E. Magistris, A. Visconti, Catalogo delle strutture fortificate dell'Alto Novarese. Analisi dei castelli di Vogogna.
Donatella Rocco, Gli Statuti del Collegio dei Giudici di Novara (secolo XVI).
Sergio Ferrario, L'Università di Pavia dal 1859 al 1899. La Facoltà di Lettere e Filosofia.
Annalisa Luzzana, Rovegro: una comunità della Vall'Intrasca tra il XVIII e il XIX secolo.
1986
Monica Aguggia, Materiale longobardo in Piemonte: la necropoli di Borgovercelli.
Franca Franzosi, Un episodio della cultura figurativa novarese: S. Maria di Garbagna e i suoi affreschi quattrocenteschi.
Angela Viotti, L'Archivio del Consorzio di S. Vittore di Intra.
Mauro Battisti, Il Comune e la società di Novara dal Regno di Sardegna all'Italia unita, 1852-1863.
Alba Lusso, Vita politica novarese nell'età della Destra Storica (1861-1876), aspetti e problemi.
Daniela Giarda, La ricostruzione del movimento sindacale nel Verbano e nel Cusio dal 1943 al 1948.
Franco Tagliaretti, Partiti politici e lotte sociali nel Novarese (1946-1948).
1987
Giannina Ferrari, Aspetti patrimoniali e urbanistici di Novara nei secoli XIII e XIV (attraverso i documenti relativi all'Ospedale della Carità).
Angelo Raimondi, San Martino di Morghengo: ipotesi storico-filologiche per un approccio al restauro.
Rossana Ottolina, San Pietro di Cerano: ipotesi filologiche per un programma di restauro.
Daniela Cantatore, Alberto Perego, San Giulio di Dulzago: percorso filologiche ed ipotesi di conservazione.
Nicoletta Bardelli, David Calderoni, Il Barocco nell'Ossola: il Santuario "della Guardia" in Ornavasso.
Gabriella Burlazzi, Le grate lignee del Sacro Monte di Varallo.
Susanna Borlandelli, Altari lignei piramidali in Valsesia dal 1663 al 1710.
Paolo Cirri, La ristrutturazione delle forze armate piemontesi nel decennio di preparazione 1849-1859.
Luciano Moia, L'organizzazione sportiva a Novara nel periodo fascista. ![]()
Ernesto Tencaioli, Valutazione auxologica delle bambine del Comune di Novara, di et fra i 4 ed i 6 anni.
1988
I due lavori, che presentiamo, vengono qui accostati perch hanno in comune alcune caratteristiche significative. In primo luogo, riguardano entrambi due nobildonne, l'una italiana e l'altra inglese, vissute nel secolo scorso.
I loro interessi furono indirizzati diversamente: la contessa Giuseppa Tornielli Bellini diede vita ad una istituzione scolastica (la Scuola d'arti e mestieri di Novara) a favore delle classi più povere della città; lady Henry-Warwick Cole, invece, compì in più riprese il giro attorno al monte Rosa, lasciando un'ampia descrizione delle valli alpine attraversate nel volume A Lady's Tour round Monte Rosa; with visits to the Italian Valley of Anzasca, Mastalone, Camasco, Sesia, Lys, Challant, Aosta and Cogne. In a series of excursions in the years 1850-56-58.
I due personaggi dunque vissero, in un certo senso, all'avanguardia rispetto al loro tempo, e ciononostante ad entrambi, fino ad ora, non sono mai stati dedicati studi particolari, tanto che l'opera della lady non è neppure stata tradotta in italiano e la memoria della contessa (forse) è tramandata solo dal nome dell'Istituto magistrale a lei dedicato.
Per la compilazione delle tesi sono stati esplorati materiali inediti: le carte dell'Istituto Bellini conservate presso l'Archivio di Stato di Novara, e le opere, in buona parte ancora in originale, dei viaggiatori inglesi dell'epoca.
Sarebbe per fuorviante insistere oltre sulle analogie tra le due nobildonne, anche se diventa spontanea almeno una considerazione sul contributo della donna alla promozione sociale e del costume, a prescindere dall'ambiente e dalla cultura di origine.
La ricerca della Panigoni documenta attraverso l'affermarsi della scuola, caratterizzata dalla massiccia frequenza femminile, un aspetto non trascurabile dell'evoluzione complessiva della città. Per l'integrazione sociale si rivelò valida la mescolanza delle allieve di umile condizione con quelle provenienti da famiglie agiate. Così la trasformazione della scuola-opificio in istituzione, dove lo studio aveva spazio preminente, segna un passo decisivo verso il riscatto dell'istruzione popolare, togliendola dall'angusta considerazione in cui era tenuta.
Il lavoro della Pitruzzella invece, oltreché presentare un vasto panorama della letteratura inglese sul viaggio in Italia, nella seconda parte contiene la traduzione dei capitoli riguardanti il viaggio da Zermatt a Varallo, con precise descrizioni della nostra zona, soprattutto della valle Anzasca e del lago d'Orta.
A buon diritto le tesi si inseriscono in quel ricco filone di studi, legati al territorio novarese, che in questi ultimi anni ha avuto uno sviluppo veramente apprezzabile.
Lino Cerutti [in BSPN LXXIX (1988)]
Angela Panigoni, L'Istituto civico Bellini di Novara: storia di una scuola di arti e mestieri (1833-1925).
Isabella Pitruzzella, Viaggio di una signora intorno al Monte Rosa.
1989
Rosa Rossi, Il Capitolo di San Giulio d'Orta e le sue proprietà dalla prima documentazione al secolo XV.
Livia Carlino, Maria Mera, Emanuela Sgobbi, Il Capitolo di San Giulio d'Orta.
Nadia Montironi, La pubblica assistenza a Novara in età napoleonica.
Antonello Rizzi, Aspetti agricoli e sociali di una zona novarese: Santa Maria della Bicocca.
Grazia Richetti, Cronaca e storia della Resistenza nel Cusio. Settembre 1943-Aprile 1945.
1991
Enrico Marini, Ugo Ferrandi. Un novarese in Somalia.
Vincenzo D'Errico, Alle origini del credito popolare.
Matteo Fornara, L'opera dei rifugiati italiani sui giornali ticinesi.
Maurizio Massa, Le "Consignationes beneficiorum" e la distribuzione della proprietà ecclesiastica nella diocesi di Novara a metà del XIV secolo.
Paola Bagnati, Susanna Del Favero, Angelica Zavettieri, La cultura del restauro di Vittorio Avondo attraverso le vicende di Palazzo Silva.
Alessandra Duchetti, La figura di Giuseppe Bronzini e la problematica del restauro in Novara tra XIX e XX secolo.
1992
Pietro Ziliani, Quintino Sella e l'Accademia dei Lincei.
1994
Paolo Volorio, Carlo Nigra architetto e restauratore.
Cristina Bussacchetti, L'identità territoriale come risorsa economica: l'imprenditoria artigiana in Valle Strona.
Andrea Musano, Politica e territorio tra Stato Visconteo e Sabaudo. Il caso di Romagnano: sviluppo e strategia.
1998
Paolo Mira, Carlo Federico Pietrasanta, ingegnere e architetto (1656-1729).
2001
Cristina Avogadro, Un aspetto della politica sanitaria in età napoleonica: la vaccinazione nel Dipartimento dell'Agogna.
Fabio Degiorgi, "I vostri mali cesseranno ben tosto". La polizia nel Dipartimento dell'Agogna fra il 1800 e il 1802.
Vanessa Landini, Le biblioteche popolari a Novara (1869-1943).
2002
Paola Drisaldi, La chiesa di San Giovanni Decollato. Vicende architettoniche.
(1) La prima segnalazione di tali lavori è stata curata da Andreino Coppo nel 1980, prima della creazone della rubrica "Thesis".
(2) Costituzioni di Sua Maestà per l'Università di Torino. Regolamenti del Magistrato della Riforma per l'Università di Torino, Stamperia Reale, Torino MDCCLXXII.
(3) Alcune tesi sono state gi segnalate nel settore Recensioni del BSPN LXXV (1984). Da questo numero viene riservato un settore specifico, «THESIS», alla segnalazione di tesi di laurea.